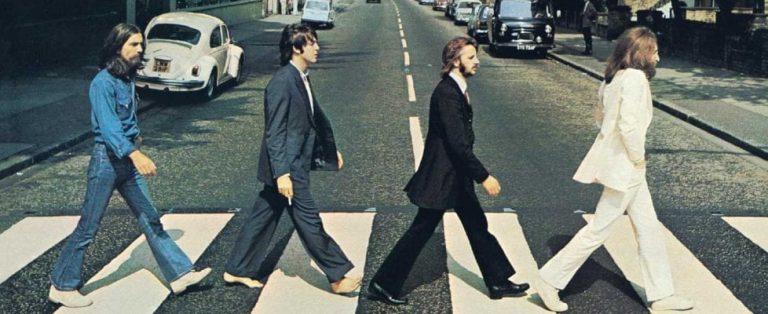Medicina nella Roma antica
di Anna Maria Panattoni

Il termine ‘medico’ si collega, nel mondo latino, alla voce verbale medeor = mi prendo cura: da qui, le origini di quelle che poi diventeranno la scienza moderna e la missione assistenziale di chi esercita la professione sanitaria.
In origine, nella Roma antica, non esistevano medici, ma chi tutelava la salute era il pater familias che decideva, fra tradizione e magia, a quali rimedi ricorrere. La pratica comune, tramandata di padre in figlio, consisteva, ovviamente, nell’avvalersi di prodotti naturali, traendo dal mondo vegetale, animale e minerale sostanze per filtri e applicazioni.
I primi medici – a quanto riporta Plinio il Vecchio (Nat. Hist., XXIX, 1-27) – sarebbero giunti nell’Urbe dalla Grecia, portando il loro bagaglio di conoscenze e di esperienza; pochi nomi noti di clinici si riconducono anche alla Palestina e all’Egitto: il consulto delle grandi personalità esterne era riservato tuttavia ai personaggi eminenti e alle famiglie patrizie del mondo romano.
In età imperiale esistevano i ‘medici di corte’, archiatri personali dell’imperatore e della domina.
È noto che Giulio Cesare avesse agevolato il trasferimento di medici a Roma, concedendo loro la cittadinanza e assicurando importanti privilegi. In tal modo dal I secolo a.C. ci furono un rilancio e uno sviluppo dell’Arte. Costituiscono importante documentazione il De medicina di Aulo Cornelio Celso (14 a.C. circa – 37 d.C. circa) e il De materia medica composto da Dioscoride Pedanio (40 – 90 d.C. circa), così come fondamentali le numerosissime opere di Galeno (129-201 d.C.), originario di Pergamo, medico personale di Marco Aurelio e Commodo.
In linea generale però chi assisteva i malati delle classi più basse era – nel migliore dei casi – un guaritore, spesso un praticone che faceva esperienza da autodidatta o consultando i testi che circolavano o nelle botteghe dei più famosi – le tabernae medicorum o medicinae – e talvolta anche un ciarlatano. Tutti costoro, al contrario dei medici blasonati, esigevano onorari accessibili anche a tasche modeste.
L’idea di malattia, nell’antichità, era spesso collegata alla punizione divina – tanto più quando le patologie erano estese –, dal momento che, in assenza di strumenti diagnostici, si ignoravano sia le origini dei mali sia i metodi di cura. In cerca di una liberazione dai morbi si ricorreva all’invocazione delle divinità con sacrifici, offerte e preghiere.
Mancando i concetti moderni di diagnosi e prognosi si andava spesso per tentativi alla ricerca di mali e cure. I sintomi non erano sempre ben riconosciuti e talora non erano catalogati e/o catalogabili, a meno che non si trattasse di epidemie, evenienze in cui, in contemporanea, tutti manifestavano gli stessi disturbi macroscopici.
Nel tentativo di ricostruire nella Roma antica i fattori eziologici delle patologie è bene considerare che molte malattie erano riconducibili all’alimentazione, alle attività svolte e allo stile di vita o erano imputabili alle scarsissime accortezze igieniche.
Va evidenziato in primis quanto fosse diffuso il consumo di cibo fermentato e come gli alimenti potessero essere conservati in luoghi e in condizioni igieniche non adatte: potevano dunque facilmente andare a male oppure essere contaminati. L’assunzione di verdure, spesso crude, provocava l’ingestione di parassiti depositatisi sulle superfici dei vegetali, principalmente attraverso le deiezioni umane e animali.
Dall’assunzione di acque non sempre pulite derivava spesso la dissenteria; la mancanza di sostanze e di metodi capaci di abbassare la carica batterica dell’acqua rendeva il veicolo idrico uno dei principali vettori delle infezioni. Non va dimenticato che nelle abitazioni private non esisteva l’acqua corrente e che i rifiuti organici venivano scaricati in strada o convogliati in fogna attraverso canali a cielo aperto.
Non immuni dalle infezioni erano anche la pelle e gli occhi.
Dai costumi della vita romana derivava il saturnismo, malattia legata all’uso comune di contenitori in piombo e all’abitudine di aggiungere al vino sali di piombo per renderlo più dolce; le infezioni alle vie urinarie e le malattie veneree, contratte spesso nei lupanari (è nota la diffusione della gonorrea), erano legate alla scarsa igiene.
Erano contesti poco salutari, dal I sec. a. C., anche le latrine pubbliche in cui, tra l’altro, era in comune l’uso dello xylospongium, definito anche tersorium (antenato dello scopino moderno): un bastone, alla cui estremità era legata una spugna, usato per pulire le latrine e il corpo, in assenza della carta igienica; esso rappresentava uno strumento di evidente trasmissione batterica così come forse i brandelli di stoffa utilizzati per il medesimo scopo.
I Romani conoscevano anche polmonite, meningite, difterite, tetano e, addirittura, in età imperiale, patologie da stress.
È nota inoltre la diffusione di morbillo, tubercolosi (dal I secolo d.C.), malaria (alias febbre di Roma), influenza, colera, brucellosi, dengue, rabbia, lebbra, tifo esantematico, vaiolo e peste bubbonica, anche se con la generica definizione di peste si definiva ogni forma di epidemia.
Grande paura destò la peste Antonina o Aureliana o peste di Galeno, pandemia probabilmente di vaiolo, diffusa e trasmessa dai soldati di Roma reduci dalle campagne militari contro i Parti. Le fonti la descrivono caratterizzata da febbre alta, pustole cutanee nere, lesioni nel cavo orale e in quello faringeo, tosse, vomito, alito fetido, ulcerazioni vescicali, insonnia e disturbi psicologici.
 Nei contesti più poveri e più sporchi o tra i soldati non era raro trovare zecche e pidocchi.
Nei contesti più poveri e più sporchi o tra i soldati non era raro trovare zecche e pidocchi.
Dal confronto della documentazione letteraria con i risultati degli esami effettuati e degli studi condotti dalla Società italiana di ortopedia e traumatologia (S.I.O.T.) su un ampio campione di resti ossei di età imperiale (I-III d.C.), è confermato che i Romani conoscessero inoltre artrosi, gotta, tumori primitivi delle ossa e metastasi e che fossero spesso sopravvissuti agevolmente a varie tipologie di fratture ossee, dal momento che erano padroni delle tecniche per manipolare, ridurre e fissare con stecche le parti lese. Indagini condotte nei contesti delle latrine e sui resti fecali hanno testimoniato invece la presenza di numerosi parassiti e vermi intestinali.
Sono attestate le pratiche di esecuzione di bendaggi e fasciature nonché di suture per le ferite e, se non la legatura dei vasi, almeno la temporanea chiusura di essi con pinzette a dentelli. È documentata la pratica chirurgica, come confermato da Celso e dall’ampia strumentazione rinvenuta nelle campagne di scavo: gli interventi di resezione degli arti (a seguito di ferite di guerra o gangrena), quelli di trapanazione del cranio e quelli alle varici, l’eliminazione della cataratta, le litotomie e gli interventi collegati al parto (è conosciuta la figura dell’ostetrica).
È noto l’uso di sonde e di cateteri, usati anche per drenare i liquidi addominali, così come di protesi dentarie fisse.
Prime strutture sanitarie, veri e propri ambulatori, erano i valetudinaria (cfr. Columella, De re rustica, XII, 38, XV, 1), presenti nelle villae, nei ludi gladiatori (palestre dei gladiatori) e negli ambienti militari, dove ovviamente occorreva impiantare ‘ospedali da campo’ e far convenire persone che fossero in grado di portare cura e conforto ai combattenti.
Non era purtroppo raro che i pazienti, dopo essersi affidati alle cure mediche, fossero ridotti in fin di vita o versassero in condizioni peggiori rispetto a quelle di partenza. Tuttavia, in assenza di autorità preposte a vigilare sull’operato e sulle prestazioni sanitarie, malgrado le disposizioni di legge dei secoli III-I a.C., che evidenziavano le responsabilità di chi non si fosse ben preso cura dei malati, si poteva far conto sulla moralità e sull’impegno autentico dei medici attraverso il solo rispetto del Giuramento di Ippocrate, testo deontologico inossidabile.