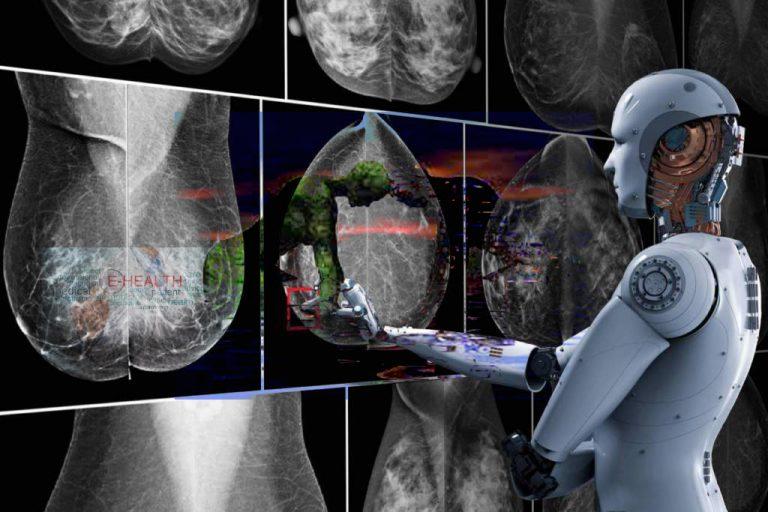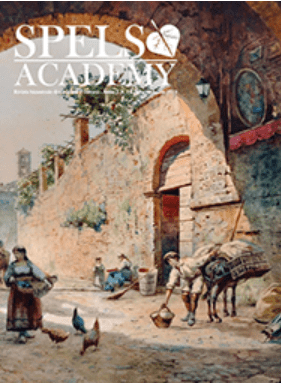COVID e nuvole… in bicicletta
di Gloria Taliani
L’aereo della Guardia di Finanza, un Boeing 767 nuovissimo e freddo come una ghiacciaia, rulla con indifferenza metallica sulla pista di Pratica di Mare, sento le mani che si aggrappano ai braccioli e le vedo impallidire. È curioso, in generale non ho paura di volare, eppure adesso mi sembra di provare qualcosa che somiglia alla paura. Ma questo non è un volo qualunque.
Stiamo puntando verso Orio al Serio, e di lì verso le destinazioni di prima linea di una guerra chiamata COVID. Una guerra che ciascuno ha scelto di combattere, ma che spaventa tutti.
Siamo distanziati uno dall’altro – bisogna rispettare la norma di sicurezza – e indossiamo mascherine che nascondono quasi tutto il volto lasciando in vista solo gli occhi. A tratti ci guardiamo cercando nello sguardo dell’altro il riflesso della preoccupazione che ci indebolisce il cuore, un po’ a tutti. Ma forse ancora di più cerchiamo quella spavalderia di cui abbiamo bisogno.
L’aereo decolla, il rumore ed il freddo sono più insistenti. Mi chiedo come sia successo che sono finita qui, su questo volo, seduta su questa poltrona, tra persone che non conosco, diretta verso una destinazione che non so, a difendere persone ignote dall’assalto di un virus cattivo, senza sapere chi di noi – io o il virus – vincerà la partita.
Chiudo gli occhi per semplice consuetudine, è facile farlo quando si vola. Ma questa volta non mi viene incontro un’immagine festosa del viaggio che verrà. Mi tornano alla mente le ultime 24 ore: la telefonata di convocazione, l’incontro in caserma con i colleghi arrivati dalle altre regioni, la corsa al tampone nasale nella sede della protezione civile, l’incontro solenne con il Ministro. Momenti lievi, di apparente spensieratezza da camerata, eppure momenti duri, che hanno interrotto la normalità della vita quotidiana.
Raccontami chi sei, cosa fai, dove lavori. Dammi una spiegazione, dimmi cosa ti ha portato qui. Tutti sappiamo che non è dato saperlo, tutti chiudiamo scrupolosamente i nostri segreti in un doppio fondo della coscienza che non ha accessi, che forse non concede l’accesso neanche a noi stessi. E per smettere di stare in ansia ci concentriamo sugli aspetti pratici, su quei dettagli che circoscriveranno il nostro stare nella pandemia di qui in avanti: la mascherina, la distanza, i guanti.
L’arrivo a Bergamo ci trova impreparati, ora non si può davvero tornare indietro. Il possibile non ha mica tante vie. Le formalità di sbarco, le autorità, i fotografi somigliano ad ostacoli che vogliamo superare con la massima agilità. Siamo stanchi e affamati. Ma questa fame è curiosità per quello che ci sta aspettando nelle corsie degli ospedali dove sappiamo che colleghi molto più stanchi di noi aspettano un aiuto per fermarsi e dimenticare l’affanno che da giorni non li lascia dormire.
 Chi ci assicura che ce la faremo?
Chi ci assicura che ce la faremo?
Lentamente ci separiamo, ognuno raggiungerà la sua destinazione: Bergamo, Sondalo, Pavia, Brescia, Piacenza. Con una certa solennità ci salutiamo e siamo già lontani, con la mente ai malati senza respiro e agli ospedali senza riposo. Con la promessa di rimanere uniti nei racconti della sera, ci avviamo verso la sede di lavoro.
Ci sono voluti solo pochi giorni perché la fatica e lo stupore iniziali diventassero abitudine. Ma non posso dimenticare l’arrivo a Piacenza, stanchi e infreddoliti. Nella loro caserma, i vigili del fuoco ci hanno accolti come fossimo un prezioso mucchietto di sale in mezzo al deserto. Tra loro, in abiti civili, un gentile signore ci ha ringraziato, dandoci il benvenuto in quello che – si capiva – doveva essere il suo inferno personale. Il direttore generale dell’Ospedale, alle dieci di sera, era lì, sotto una pioggerella insistente e fredda, ad aspettare l’arrivo dei volontari della Protezione Civile, pronto a risolverne i problemi e grato che avessimo deciso di alleviare qualcuno dei suoi. Il viso stanco nascosto dalla mascherina di ordinanza, gli occhi stretti in uno sguardo preoccupato ma anche un po’ sollevato dalla nostra presenza, che la sua mente agilmente stava ricalcolando in termini di tempo-uomo, di qui in avanti al servizio dell’ospedale.
Pochi momenti rimarranno vivi nella memoria come l’accoglienza di quella sera. L’uomo è per sua natura comparativo, ed era fatale che la mente andasse ad altre figure intente a ricoprire in altri luoghi e assai più scialbamente il ruolo di DG. Però è prevalsa, come spesso mi accade, la consolazione: se esiste una persona così, c’è posto per la speranza. E quella non sarebbe stata l’unica prova che la speranza del buon governo è non solo ragionevole e giusta, ma è soprattutto un dovere. L’unica fede alla quale valga la fatica di tener fede per adesso e per domani.
 L’Ospedale Guglielmo da Saliceto è un luogo fuori dal tempo, un incontro formidabile di antico Monastero del ‘400 e modernissima rianimazione. Disteso su prati verdi curatissimi e bordato di balaustre a colonnine, è un posto dove la malattia, per quanto orribile, sembra persino più tollerabile. Nel suo perimetro tutti si aggirano svelti, c’è tanto da fare e l’ingranaggio è in continuo movimento e funziona bene. Si ha la certezza che ciò che deve essere fatto lo sarà, che se oggi qualcosa non è andato per il verso giusto, qualcuno domani ci metterà mano e testa per correggere il tiro, e fin nei piccoli dettagli si capisce che c’è la cura per l’insieme e per il dettaglio. E che cura! Percorsi ben tracciati, risoluzione efficiente di problemi estemporanei, previsione di bisogni futuri… un ospedale che in poche settimane ha cambiato pelle tante volte quante è stato necessario per fronteggiare l’assalto. Che prova incredibile! Parola d’ordine: resistere. Lo ripete incessante anche la Basilica di Santa Maria di Campagna. Al mattino, certe nuvole ne accarezzano la piccola torre campanaria, il tiburio a pianta ottagonale, poi se ne vanno via lente e si sciolgono soddisfatte mentre lei troneggia sul piazzale da cui ha preso il via la prima crociata e veglia paziente sulle finestre del Reparto di Malattie Infettive. Lì, in quel reparto, dentro i caschi della ventilazione non invasiva i pazienti, storditi, non guardano mai il cielo e per loro le nuvole sono passate invano. A loro resta solo il rumore dell’ossigeno soffiato a tutta forza dai tubi erogatori, la fatica di trattenerne il necessario per non perdere la coscienza, la speranza che domani sia più che una parola e non solo una speranza.
L’Ospedale Guglielmo da Saliceto è un luogo fuori dal tempo, un incontro formidabile di antico Monastero del ‘400 e modernissima rianimazione. Disteso su prati verdi curatissimi e bordato di balaustre a colonnine, è un posto dove la malattia, per quanto orribile, sembra persino più tollerabile. Nel suo perimetro tutti si aggirano svelti, c’è tanto da fare e l’ingranaggio è in continuo movimento e funziona bene. Si ha la certezza che ciò che deve essere fatto lo sarà, che se oggi qualcosa non è andato per il verso giusto, qualcuno domani ci metterà mano e testa per correggere il tiro, e fin nei piccoli dettagli si capisce che c’è la cura per l’insieme e per il dettaglio. E che cura! Percorsi ben tracciati, risoluzione efficiente di problemi estemporanei, previsione di bisogni futuri… un ospedale che in poche settimane ha cambiato pelle tante volte quante è stato necessario per fronteggiare l’assalto. Che prova incredibile! Parola d’ordine: resistere. Lo ripete incessante anche la Basilica di Santa Maria di Campagna. Al mattino, certe nuvole ne accarezzano la piccola torre campanaria, il tiburio a pianta ottagonale, poi se ne vanno via lente e si sciolgono soddisfatte mentre lei troneggia sul piazzale da cui ha preso il via la prima crociata e veglia paziente sulle finestre del Reparto di Malattie Infettive. Lì, in quel reparto, dentro i caschi della ventilazione non invasiva i pazienti, storditi, non guardano mai il cielo e per loro le nuvole sono passate invano. A loro resta solo il rumore dell’ossigeno soffiato a tutta forza dai tubi erogatori, la fatica di trattenerne il necessario per non perdere la coscienza, la speranza che domani sia più che una parola e non solo una speranza.
Viene voglia di accarezzarli tutti: Franca, Maria, Paolo, Stefano, Dario, Emilia… e via e via in una processione di nomi che si attaccano a fatica a quei volti stanchi, sudati, persi nella sofferenza e in chissà quali pensieri. Guardano all’indietro e cercano di ricordare i momenti più belli della propria vita? O cercano con ostinazione la forza per immaginarne una nuova, di vita, mentre sono chiusi dentro stanze a pressione negativa, con la testa avvolta da una bolla d’aria a pressione positiva che non è per niente leggera e non vola da nessuna parte.
Li guardiamo respirare con una fatica innaturale, come se avessero perso la memoria di un gesto tanto naturale quanto inconsapevole che con diligenza cercano di imparare nuovamente. Come bambini chini sul banco che, con la matita, provano a tracciare le prime lettere della loro storia. Per un po’ ci sentiamo fratelli, anche noi sudati e quasi soffocati dalle tute, dalle mascherine, dalle maschere facciali, dal doppio paio di guanti. Non c’è un centimetro di pelle a contatto con l’aria e lentamente la loro fame di ossigeno diventa la nostra. E poi le loro storie, scritte nelle cartelle cliniche, a volte aggiungono alla sofferenza del presente la testimonianza di un incredibile accanimento del passato. Mariti, mogli, genitori o fratelli persi nella guerra persa contro il virus ai quali non si capisce se il parente sopravvissuto voglia davvero sopravvivere. E l’assistenza si tramuta in compatimento, un magone silenzioso e condiviso tra medici e infermieri che non trovano un codice per elaborare questo presente e tracciare un possibile futuro. Che ne sarà di tutto questo dolore?
 Dalla finestra del mio albergo, al mattino, vedo solo cielo. In questi giorni tra marzo e aprile è spesso limpido, intensamente azzurro, ma ogni tanto appare qualche nuvola che mi piace rincorrere mentre pedalo sulla bicicletta rossa che l’ospedale ha messo a disposizione. Il vento che sospinge quelle nuvole dalle forme bizzarre fatalmente rievoca il vento che soffia nei caschi in corsia. E mentre pedalo guardando il cielo con il naso schiacciato sotto la mascherina mi chiedo come farò ad affrontare una nuova giornata. Ma l’aria è pulita e fresca, il cigolio dei pedali è dolcissimo e penso che siccome ormai siamo arruolati in questa guerra, la combatteremo anche oggi. Per adesso si combatte. I conti li faremo poi.
Dalla finestra del mio albergo, al mattino, vedo solo cielo. In questi giorni tra marzo e aprile è spesso limpido, intensamente azzurro, ma ogni tanto appare qualche nuvola che mi piace rincorrere mentre pedalo sulla bicicletta rossa che l’ospedale ha messo a disposizione. Il vento che sospinge quelle nuvole dalle forme bizzarre fatalmente rievoca il vento che soffia nei caschi in corsia. E mentre pedalo guardando il cielo con il naso schiacciato sotto la mascherina mi chiedo come farò ad affrontare una nuova giornata. Ma l’aria è pulita e fresca, il cigolio dei pedali è dolcissimo e penso che siccome ormai siamo arruolati in questa guerra, la combatteremo anche oggi. Per adesso si combatte. I conti li faremo poi.